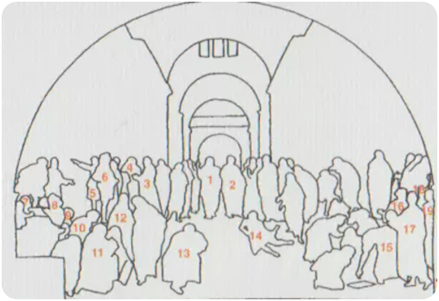Libertà e Giustizia non è un partito politico, ma un’associazione di cultura politica, ispirata ai due principi indicati nella sua stessa denominazione. Il suo metodo è la ragione applicata ai fatti. Allontaniamoci, allora, un poco dai particolari della cronaca politica quotidiana e cerchiamo di intravedere l’insieme dei fatti per ricavarne linee di pensiero e d’azione. Sempre che non sia un esercizio inutile.
IDEE-FATTI
Nella vita politica, le idee, le percezioni, le illusioni e le indignazioni che contano non sono necessariamente quelle veritiere. Sono quelle che permeano le coscienze, fanno senso comune e muovono i comportamenti dei grandi numeri, vere o false che siano. In ogni caso, sono semplificazioni e, proprio per questo, sono efficaci. Poiché sono efficaci, esse sono, per l’appunto, “fatti”, non effimere impressioni che passano da sé.
a. La prima idea-fatto – inutile dirlo – si esprime con la parola “casta”: giri intrecciati di potere politico, burocratico, economico e finanziario che si auto-alimentano per nepotismo e cooptazione, in base a patti di protezione e fedeltà; potere per il potere, inamovibile, spesso occulto e illegale; disuguaglianze crescenti tra chi sta dentro e chi fuori, chi sopra e chi sotto; privilegi e stili di vita incomparabili; ricchezza crescente per pochi e povertà dilagante tra i molti. Una grande divisione sociale, per la quale, un tempo, fu coniata l’espressione “razza padrona”.
La lotta di classe pare diventare, o già essere diventata lotta di casta, e a parti invertite: non degli sfruttati contro gli sfruttatori, ma degli sfruttatori contro gli sfruttati. Forse, ancora non si percepisce la dimensione globale di questa immensa ingiustizia, rispetto alla quale gli abusi, le corruttele, i furti di casa nostra, per quanto insopportabili, sono quisquilie. Quando si percepirà, cioè si farà strada l’idea, la reazione sarà la restaurazione delle piccole patrie, delle piccole comunità, come rifugi al tempo stesso protettivi e aggressivi: una vecchia storia.
b. La seconda idea-fatto è l’identificazione del potere che s’è detto con le Istituzioni. La politica moderna si basa sulla distinzione tra le istituzioni e coloro che le impersonano e le servono. L’idea odierna è il rovesciamento: coloro che stanno nelle istituzioni se ne servono. In tal modo, ogni degenerazione dei primi viene percepita come vizio delle seconde. Una volta, la corruzione di uno, era vista come corruzione di quello, poi del suo partito, poi dei partiti tutti quanti, poi della politica come tale, infine delle istituzioni tutte quante. I corrotti, gli insipienti, i dilettanti, gli arroganti, ecc. che operano nelle istituzioni non sono solo cattivi soggetti per se stessi, ma lo sono anche di più per le istituzioni democratiche. Nessuna azione antidemocratica è più efficace della corruzione e della propaganda che si basa su di essa. Anche questa è una vecchia storia.
c. La terza idea-fatto è che tutto s’equivale e che “sono tutti uguali”. Di conseguenza, non c’è nulla di possibile e nessuno di cui ci si possa fidare. Tanto vale, allora, starsene a guardare, sperando nella palingenesi, cioè nel crollo della politica e delle sue istituzioni e nell’apparizione di qualcuno che faccia piazza pulita. Che questa prospettiva esista e possa diventare persino maggioritaria è il crimine maggiore che dobbiamo imputare alla generazione che è la nostra. Di nuovo, ci appaiono i fantasmi d’una vecchia storia che si deve sapere dove porta.
LE RISPOSTE VUOTE
Queste generalizzazioni sono sbagliate. Sono anzi trappole pericolose. Ma sono fatti.
Come le vediamo contrastare? Con vuote banalità e con azioni controproducenti.
La prima banalità è l’accusa di antipolitica, che evita di fare i conti con le ragioni che allontanano dalla politica e si presta, contro chi la pronuncia, a essere ritorta con la stessa, se non con maggiore forza. Chi è, infatti, il vero antipolitico? La domanda è a risposta aperta. Non serve a nulla l’anatema. Serve solo la buona politica.
Non bastano le parole, quelle parole che si possono pronunciare a basso costo; parole banali anch’esse, che non vogliono dire nulla perché non si potrebbe che essere d’accordo.
Nella politica, che è il luogo delle scelte e delle responsabilità, dovrebbe valere la regola: tutte le parole che dicono ciò che non può che essere così, sono vietate.
Non vogliono dire nulla riforme, moralità, rinnovamento, innovazione, merito, coesione, condivisione, giovani, generazioni future, ecc.: vuota retorica del nostro tempo che tanto più si gonfia di “valori”, tanto più è povera di contenuti.
Chi mai direbbe d’essere contro queste belle cose?
COME USCIRNE
1) ATTI DI CONTRIZIONE E SEGNI DI DISCONTINUITA’
Alle vuote parole che non costano niente, corrispondono azioni e omissioni nefaste, anzi suicide. Si scoprono ora (!) ruberie, inimmaginabili nel mondo normale, e s’invoca subito una legge sui partiti e sul controllo dei flussi di denaro che arrivano loro: una legge che non si farà.
Si scopre ora (!) che la corruzione dilaga e si fa una legge-manifesto che, anche a dire di quelli che, all’inizio, l’hanno appoggiata, servirà poco o nulla.
Ci si accorge ora (!) che gli organi elettivi sono pieni di gente impresentabile e si prepara una legge sulle candidature. Leggi, sempre leggi, destinate a non farsi o, se fatte, a essere svuotate.
Ma nessuno obbliga a rubare, a corrompere e farsi corrompere, promuovere candidati senza qualità o con ben note “qualità”.
I cattivi costumi si combattono con buoni costumi. Le leggi servono a colpire le devianze, ma nulla possono quando la devianza s’è fatta normalità. Prima di cambiare le leggi, occorre cambiare se stessi e, per cambiare se stessi, non occorre alcuna legge.
Per chiedere rinnovata fiducia, occorrono ATTI DI CONTRIZIONE, segni concreti di discontinuità, non “segnali”, come si dice per dissimulare l’inganno.
Non è un segno, ma un segnale, per di più autolesionistico, la legge elettorale che è in gestazione. Mai più al voto con la legge attuale, s’era detto. Impedito il referendum da un’improvvida sentenza della Corte costituzionale, il problema della riforma è passato al Parlamento, cioè a chi ha da sperare vantaggi o temere svantaggi. Ci voleva poco a capire che, in prossimità delle elezioni, sondaggi alla mano, tutto sarebbe dipeso da calcoli interessati e poco o nulla da buone ragioni di giustizia elettorale. Non c’è bisogno di apprenderlo dal “Codice di buona condotta in materia elettorale” (§§ 65 e 66), che contiene il “minimo etico” segnalato agli Stati dal Consiglio d’Europa nel 2002. Lo comprendiamo da soli.
Comprendiamo che la nuova legge elettorale, se ci sarà, dipenderà dagli interessi dei partiti, non degli elettori che vi troveranno ulteriori ragioni di distacco o di rabbia. La riforma, che avrebbe dovuto servire a riavvicinare eletti ed elettori, allargherà la distanza.
Si persevera, invece, tentando di ritagliarsi comunque un posto o un posticino che conti qualcosa, in una barca che rischia di andare a fondo con quelli che ci sono dentro. Si pensa che non ce ne si accorga? e che ciò non porti altra acqua a chi vuol affondarla? Che insipienza!
2) UNA STAGIONE COSTITUZIONALE PER VIVERE IN LIBERTA’ E GIUSTIZIA
Dove appoggiarsi per uscire dal pantano, per suscitare coraggio, energie, entusiasmo, in un momento di depressione politica come quello che viviamo?
Dove trovare l’ideale d’una società giusta, che meriti che si mettano da parte gli egoismi e i privilegi particolari, che ci renda possibile intravedere una società in cui noi, i nostri figli e i figli dei nostri figli, si possa vivere in libertà e in giustizia?
È sorprendente che non si pensi che questo ideale, questo punto d’appoggio c’è, ed è la COSTITUZIONE. Ed è sorprendente che si sia chiuso in una parentesi quel referendum del giugno 2006 in cui quasi sedici milioni di cittadini si sono espressi a sostegno dei suoi principi.
Altrettanto sorprendente è che non si dia significato – forse perché non se ne ha nemmeno sentore – all’entusiasmo che accoglie, tra i giovani soprattutto, ogni discorso sulla Costituzione, sul suo significato storico e sul valore politico e civile attuale. Non c’è qui una grande forza che attende d’essere interpellata per cambiare la società?
Non è paradossale che ci si volga indietro per guardare avanti.
Le difficoltà in cui ci troviamo non derivano dalla Costituzione, ma dall’ignoranza, dal maltrattamento, dall’abuso, talora dalla violazione che di essa si sono fatti. Eppure lì si trova almeno la traccia della risposta ai nostri maggiori problemi.
- Il LAVORO come diritto a fondamento della vita sociale, e non la rendita finanziaria e speculativa;
- i DIRITTI CIVILI e non le ipoteche confessionali e ideologiche sulle scelte ultime della vita;
- l’UGUAGLIANZA di fronte alla legge e non i privilegi per proteggere i deboli e combattere le mafie d’ogni natura;
- l’impegno a promuovere politiche di EQUITA’ SOCIALE E FISCALE e non l’autorizzazione a gravare sui più deboli per risolvere i problemi dei più forti;
- la garanzia dei SERVIZI SOCIALI e non la volontà di ridurli o sopprimerli;
- la SALUTE come diritto e non come privilegio;
- l’ISTRUZIONE attraverso la scuola pubblica aperta a tutti e non i favoritismi alla scuola privata;
- la CULTURA, i BENI CULTURALI, la NATURA come patrimonio a disposizione di tutti, sottratti agli interessi politici e alla speculazione privata;
- la libera INFORMAZIONE, come diritto dei cittadini e diritto-dovere dei giornalisti; ancora:
- la POLITICA come autonomo discorso sui fini e non come affare separato di professionisti o tecnici esecutivi;
- la partecipazione all’EUROPA come via che porti alla pace e alla giustizia tra le nazioni, a più libertà e più democrazia, non più burocrazia e meno libertà.
In generale, nella Costituzione troviamo la politica, il bene pubblico che più, oggi, scarseggia.
Invece, ancora una volta, come da trent’anni e più a questa parte, si ripete la stanca litania della prossima stagione come “stagione costituente”. Costituente di che cosa? Volete dire, di grazia, che cosa volete costituire? E credete con questa formula di ottenere consensi, tra cui i nostri consensi? Non viene in mente a nessuno che il nostro Paese avrebbe bisogno, piuttosto, di una “STAGIONE COSTITUZIONALE” e che chi facesse sua questa parola d’ordine compirebbe un atto che metterebbe in moto fatti, a loro volta produttivi d’idee, anzi d’ideali?
(tra i sottoscrittori: Zagrebelsky, Bonsanti, Eco, Saviano, Ginsborg, Lerner, Abate, Dalla Chiesa, Natale, Landini, Barbacetto, Settis)